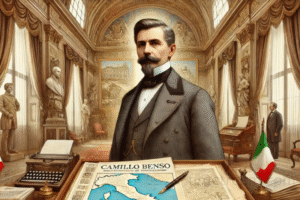1861: proclamazione del Regno d’Italia, tra unificazione e compromesso

Introduzione
Il 17 marzo 1861 segna una data cruciale nella storia d’Italia: la proclamazione del Regno d’Italia. Dopo decenni di insurrezioni, guerre d’indipendenza, diplomazia e patriottismo, la penisola italiana compiva un passo epocale verso l’unificazione. Tuttavia, quel giorno non rappresentò il traguardo finale, ma piuttosto un compromesso, un punto d’incontro tra forze differenti, spesso in conflitto tra loro: monarchici e repubblicani, federalisti e centralisti, Nord e Sud. L’Italia era proclamata nazione, ma la sua identità era ancora tutta da costruire. Come osservò Massimo D’Azeglio: “Abbiamo fatto l’Italia, ora dobbiamo fare gli italiani.” Questo blog approfondisce le dinamiche complesse, le strategie politiche, i sacrifici e le contraddizioni che accompagnarono la nascita dello Stato italiano moderno.
Dalla pluralità degli Stati alla visione nazionale
Fino alla metà del XIX secolo, la penisola italiana era un mosaico di Stati: il Regno di Sardegna, il Regno delle Due Sicilie, lo Stato Pontificio, il Granducato di Toscana, il Ducato di Modena, il Ducato di Parma e il Lombardo-Veneto sotto dominio austriaco. Ogni entità politica aveva una propria amministrazione, moneta, esercito e leggi. Tuttavia, nel corso dell’Ottocento, si diffuse l’idea di una nazione italiana unita, sostenuta da intellettuali come Giuseppe Mazzini, che promosse un’unificazione repubblicana fondata sul popolo. Anche Carlo Cattaneo e altri federalisti immaginavano un’Italia libera ma articolata in autonomie regionali. All’estremo opposto, i monarchici liberali vedevano nel Regno di Sardegna e nella dinastia Savoia la guida ideale per l’unità. La convergenza tra queste diverse visioni si materializzò solo parzialmente, con compromessi che sacrificarono ideali in nome della realpolitik. Il principio di nazionalità, già affermatosi in Europa dopo il Congresso di Vienna, trovò nell’Italia un terreno fertile per trasformarsi in rivoluzione politica e progetto statale concreto.

La strategia sabauda: diplomazia e guerra per l’unificazione
Il Regno di Sardegna, guidato dal conte di Cavour e dal re Vittorio Emanuele II, divenne il motore principale del processo unitario. Cavour comprese che senza l’appoggio delle potenze europee non sarebbe stato possibile sfidare l’Austria, la potenza che occupava la Lombardia e il Veneto. Partecipò alla Guerra di Crimea (1855) per ottenere un posto nei negoziati internazionali, e successivamente strinse l’accordo di Plombières con Napoleone III nel 1858. La Seconda Guerra d’Indipendenza (1859) portò all’annessione della Lombardia. Ma fu soprattutto grazie all’entusiasmo popolare e ai plebisciti che altri territori si unirono al Piemonte. Le regioni dell’Italia centrale (Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria) chiesero l’annessione al Regno sabaudo nel 1860. La Spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi contribuì in maniera decisiva a portare il Sud sotto la corona di Vittorio Emanuele II. Tuttavia, ogni passaggio fu accompagnato da tensioni tra l’approccio rivoluzionario e quello diplomatico, tra la spinta popolare e il controllo monarchico. “L’unità si fa passo a passo,” affermava Cavour, ma ogni passo comportava una rinuncia a qualcosa.
Il Sud e l’incontro di Teano: tra liberazione e conquista
La Spedizione dei Mille, avviata nel maggio 1860, fu accolta con entusiasmo da molti strati della popolazione meridionale, ma il processo di annessione al Regno di Sardegna non fu privo di contrasti. Giuseppe Garibaldi, convinto repubblicano, avrebbe voluto proclamare la Repubblica del Sud e garantire maggiore autonomia al popolo. Ma le pressioni politiche e militari portarono all’incontro con Vittorio Emanuele II il 26 ottobre 1860 a Teano, dove Garibaldi riconobbe il re come guida dell’Italia unita. Questo gesto, pur celebrato come atto di unità nazionale, fu anche un segno di sottomissione politica. Molti meridionali percepirono l’unificazione come una conquista piuttosto che una liberazione. Lo stesso Garibaldi si ritirò in silenzio dopo aver consegnato i territori conquistati. Le tensioni non tardarono ad emergere: nel Sud esplose il fenomeno del brigantaggio, espressione di disagio sociale, economico e politico. La narrazione ufficiale esaltava l’unità, ma nella realtà si trattava di una fusione asimmetrica, gestita con metodi spesso autoritari.
Il Parlamento del Regno d’Italia: unificazione o centralizzazione?
Il primo Parlamento del Regno d’Italia si riunì a Torino nel 1861, proclamando Vittorio Emanuele II “Re d’Italia per grazia di Dio e volontà della nazione”. L’atto fu carico di significati simbolici e politici. Tuttavia, la struttura statale adottata fu fortemente centralista: le leggi piemontesi vennero estese a tutto il territorio, senza adattamenti alle realtà locali. Questa scelta, motivata dal bisogno di uniformità amministrativa, finì per ignorare le diversità storiche, culturali ed economiche delle diverse regioni. Molti funzionari furono inviati dal Nord per “piemontesizzare” l’apparato statale. Le scuole, i tribunali, la burocrazia furono unificate sotto un unico modello. Ciò generò malcontento, specialmente nel Sud, dove la popolazione si sentì esclusa dal processo decisionale. “L’unità non si fa con un timbro,” scriveva ironicamente il giornalista napoletano Pasquale Villari. Questa tensione tra unificazione e assimilazione fu una delle contraddizioni più forti del nuovo Stato.

Chi resta fuori: Roma e il Veneto
Nonostante la proclamazione ufficiale del Regno d’Italia nel 1861, due città fondamentali per il sentimento nazionale rimasero escluse: Roma e Venezia. Roma era ancora sotto il controllo del Papa, protetto dalla guarnigione francese. Per Cavour, Roma era la capitale naturale dell’Italia unita, ma ogni tentativo di conquistarla militarmente avrebbe significato uno scontro diretto con la Chiesa e la Francia. Il Veneto, invece, rimaneva sotto l’impero austriaco. L’unità proclamata era quindi incompleta. Il sogno risorgimentale si trovava sospeso tra celebrazione e attesa. “Roma è la nostra Gerusalemme,” disse Cavour nel suo ultimo discorso in Parlamento, pochi mesi prima di morire. La sua scomparsa, nel giugno 1861, lasciò l’Italia unita ma orfana del suo più abile stratega. Il completamento dell’unificazione sarebbe avvenuto solo con la Terza guerra d’indipendenza (1866) e la presa di Roma (1870), eventi che segnarono definitivamente il processo di costruzione nazionale.
Conclusione
La proclamazione del Regno d’Italia nel 1861 fu un traguardo storico, ma anche l’inizio di nuove sfide. L’unificazione territoriale era stata ottenuta, ma quella culturale, sociale e politica era ancora lontana. Il compromesso tra monarchia e repubblicanesimo, tra Nord e Sud, tra aspirazioni popolari e strategie diplomatiche fu necessario, ma non privo di effetti collaterali. L’Italia si presentava al mondo come nazione, ma il prezzo dell’unità fu spesso l’omologazione forzata e la marginalizzazione di alcune identità locali. Solo rileggendo quella stagione con spirito critico possiamo capire quanto l’Unità d’Italia sia stata un’opera grandiosa e imperfetta, fatta di eroismi e rinunce, di visioni e di compromessi. Un punto di partenza, non un punto di arrivo.